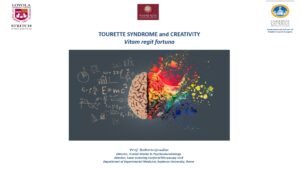La Sindrome di Tourette: tra neuroscienze, clinica e creatività
Intervista al Prof. Roberto Gradini, direttore del Master in Psiconeurolobiologia Università La Sapienza di Roma
di Ludovica Zurzolo
La Sindrome di Gilles de la Tourette è un disturbo del neurosviluppo che si manifesta tipicamente durante l’infanzia e l’adolescenza con tic motori e vocali, che possono presentarsi con intensità diversa e compromettere la qualità di vita dei pazienti. È una condizione complessa e altamente eterogenea che coinvolge fattori genetici, alterazioni delle reti neuronali e comorbidità psichiatriche quali il disturbo ossessivo-compulsivo, l’ADHD, l’ansia, la depressione o disturbi del sonno.
Per approfondire questo tema da un punto di vista neuroscientifico e clinico, abbiamo intervistato il Prof. Roberto Gradini, patologo e direttore del Master in Psiconeurolobiologia presso l’Università La Sapienza di Roma, autore di una recente relazione sulla Sindrome.
Professore, iniziando dalle basi. Cosa intendiamo esattamente per “tic”?
“I tic sono movimenti o vocalizzazioni improvvisi, rapidi, ripetitivi e non finalizzati. Si distinguono in tic motori e vocali, a loro volta classificati in semplici e complessi. I tic motori semplici coinvolgono singoli gruppi muscolari, come ammiccare o schioccare le dita, mentre quelli complessi interessano più gruppi muscolari e comportano sequenze più articolate, come smorfie accompagnate da inclinazioni del capo o movimenti ampi del corpo.
Per quanto riguarda i tic vocali, quelli semplici includono suoni, grugniti o colpi di tosse; quelli complessi possono consistere in parole o frasi, talvolta inappropriate o involontariamente offensive (coprofenomeni), anche se queste sono presenti solo in una minoranza di casi”.
Cosa ci dicono oggi le neuroscienze sulle cause della Sindrome di Tourette?
“La fisiopatologia della Sindrome non è ancora del tutto chiara, anche perché parliamo di una condizione multifattoriale, influenzata da varianti genetiche e da alterazioni delle reti neuronali. I geni implicati sono coinvolti in processi chiave come lo sviluppo dendritico, la formazione degli assoni, la trasmissione sinaptica, la produzione di neurotrasmettitori (come dopamina, istamina, oppioidi) e la regolazione dell’attività gliale e immunitaria. A livello delle reti cerebrali, i tic sembrano associati a disfunzioni inibitorie nei gangli cortico-striatali, in particolare nei microcircuiti inibitori dello striato, con un’alterata capacità del cervello di sopprimere automaticamente i movimenti indesiderati”.
Quali sono i meccanismi neurologici alla base dei tic nella Sindrome di Tourette, e quanto sono percepiti come involontari dai pazienti?
“La Sindrome di Tourette è legata a un’alterata regolazione dei circuiti cerebrali che gestiscono il controllo dei movimenti e degli impulsi motori. Tra i principali neurotrasmettitori coinvolti c’è la dopamina, il cui rilascio anomalo può contribuire al rinforzo involontario dei tic. Questo fenomeno è legato alla cosiddetta memoria delle abitudini: l’attivazione ripetuta di determinati circuiti neurali rende il tic sempre più automatico e resistente all’inibizione. Nonostante questo meccanismo, i pazienti non sempre percepiscono i tic come del tutto involontari. Spesso sono preceduti da una sensazione chiamata segno premonitore, una sorta di tensione o urgenza interna che si allevia solo dopo l’esecuzione del tic. Questo rende la Sindrome una condizione neurologica ancora più peculiare, poiché coinvolge meccanismi sia automatici che semi-volontari”.
Alcuni studi ipotizzano un legame tra la Sindrome di Tourette e particolari forme di creatività. Cosa sappiamo in merito? Ci sono esempi noti nella storia?
“È affascinante notare come diversi studi suggeriscano che la Sindrome di Tourette, nonostante le sue manifestazioni disfunzionali, possa essere associata a maggiore attivazione di circuiti cerebrali complessi, probabilmente all’origine di forme elevate di creatività. In effetti, molti soggetti con la Sindrome mostrano spiccate capacità artistiche, musicali o intellettive. Secondo diverse ricostruzioni storiche, Mozart potrebbe esserne stato affetto, insieme ad altre condizioni come ADHD, disturbo ossessivo-compulsivo o addirittura disturbo bipolare”.
Cosa si sente di dire a chi entra in contatto con persone affette dalla Sindrome di Tourette, soprattutto in ambito scolastico o familiare?
“Serve prima di tutto comprensione, e poi formazione. Non si tratta di un semplice “tic nervoso”, né una bizzarria caratteriale. È una condizione neurologica complessa, che merita un approccio multidisciplinare, empatico e competente. La scuola può fare molto, ma è fondamentale che anche le famiglie abbiano accesso a percorsi di supporto psicologico, se necessario. In conclusione, comprendere la Sindrome di Tourette richiede uno sguardo integrato, capace di tenere insieme i dati della ricerca neuroscientifica, le manifestazioni cliniche e l’unicità delle traiettorie individuali”.
Come ha spiegato il Prof. Gradini, la sfida per i professionisti e per la società è duplice: superare lo stigma legato ai tic e favorire una cultura della complessità, dove la diversità neurologica venga accolta e non ridotta a semplificazioni. Anche attraverso strumenti come la formazione psiconeurolobiologica e la divulgazione scientifica.